Eventi e Cultura
Fumettibrutti, incontro con Josephine Yole Signorelli: “Tutte le mie cose belle sono rifatte”
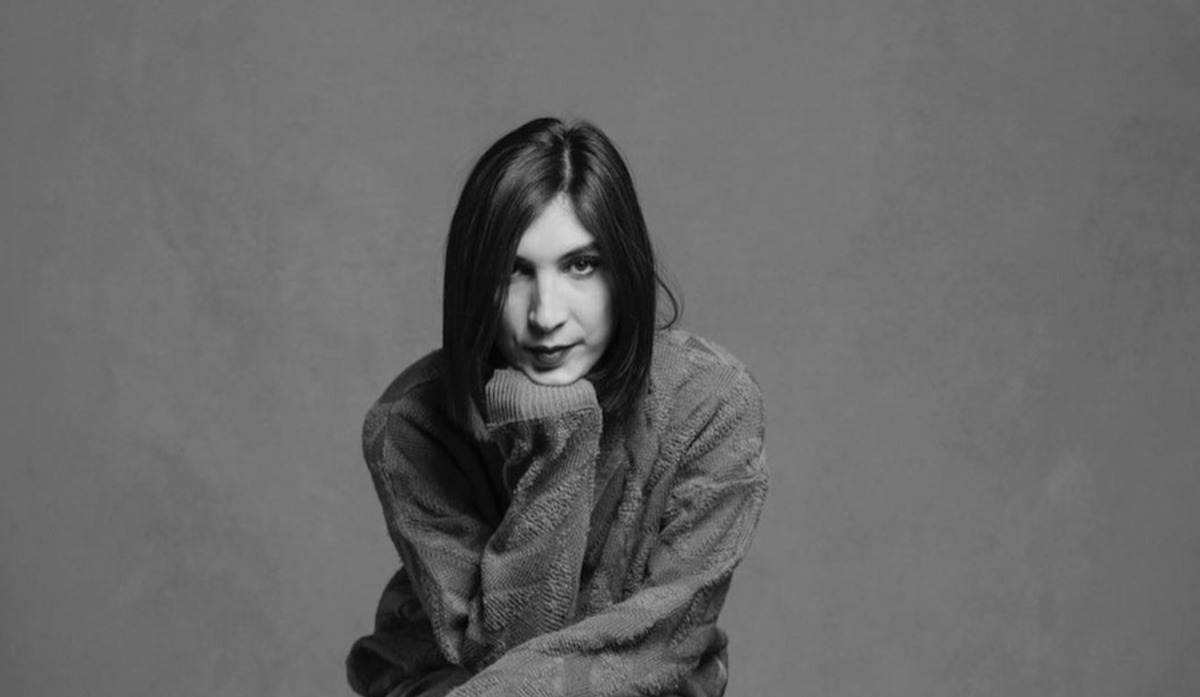
Ci sono autrici che non si limitano a raccontare la realtà, ma la attraversano con il corpo, con la biografia e con una radicalità che non chiede permesso. Josephine Yole Signorelli – conosciuta come Fumettibrutti – appartiene a questa categoria di voci necessarie, capaci di trasformare la vulnerabilità in linguaggio e il dolore in visione. Con un tratto crudo, poetico e asciutto, e con una scrittura che non ha paura di esporsi, mette a nudo identità, relazioni, traumi e rinascite, restituendo al fumetto il suo potere politico ed emotivo.
Il suo ultimo libro, “Tutte le mie cose belle sono rifatte” (Feltrinelli), è un diario disarmante e lucidissimo sul corpo come campo di battaglia e di liberazione, un racconto che sfida la norma e svela quanto spesso ciò che definiamo “naturale” sia solo cultura, sguardo, giudizio.
definiamo “naturale” sia solo cultura, sguardo, giudizio.
Sabato 22 novembre, alle ore 21, Fumettibrutti sarà ospite del Foiano Book Festival, nella Galleria Furio del Furia, per presentare questo nuovo lavoro in un dialogo pubblico con Arianna Terzoni. Sarà l’occasione per incontrare un’artista che negli ultimi anni ha cambiato il modo di pensare e fare fumetto in Italia, aprendo spazi e immaginari che prima non c’erano — o che non avevamo ancora avuto il coraggio di vedere.
Sabato sarai a Foiano e vorrei partire parlando del tuo ultimo libro “Tutte le mie cose belle sono rifatte” (Feltrinelli Comics). Il volume si apre con una dedica: “A tutte le Dalila”. Chi sono, per te, le Dalila?
Non voglio fare spoiler, perché nel finale del libro questa cosa viene spiegata. Le Dalila sono le persone che, nella loro vulnerabilità, si sono trovate vittime di transfobia e misoginia. Sono figure reali, esistenze marginalizzate, ed è a loro che ho voluto dedicare il libro.
Anche il titolo “Tutte le mie cose sono belle e sono rifatte” è particolare. È una provocazione? Una confessione? O una rivendicazione d’orgoglio?
Sicuramente suona provocatoria, e lo so. Però nasce da un’intuizione legata al monologo finale del film “Tutto su mia madre”, dove la protagonista elenca con fierezza ciò che ha rifatto e dice che ognuno è più autentico quando somiglia all’immagine che ha di sé. Per me questo titolo è un modo ironico e potente per parlare di identità, corpo, chirurgia, autenticità. E mi ha dato la possibilità di raccontare parti della mia transizione che non avevo mai affrontato prima. Soprattutto in un periodo storico in cui si parla molto (spesso senza conoscenza) di adolescenti trans: mi interessava portare una testimonianza reale, non un’opinione astratta.
In Toscana abbiamo approvato una piccola legge sul tema della transfobia e c’è stato un attacco violentissimo da parte della destra. Questo clima lo senti anche tu?
Assolutamente sì. Siamo tra argomento da talk show e bersaglio politico. E la cosa paradossale è che spesso chi dice di “difendere la famiglia” è lo stesso che massacra pubblicamente le famiglie con figli trans. Viviamo in una fase di post-verità: basta dire qualcosa perché diventi narrativamente più potente della realtà scientifica, o dell’esperienza delle persone coinvolte.
Hai scelto il fumetto come linguaggio. In Italia è ancora percepito come un linguaggio minore o sta cambiando qualcosa?
Credo stia cambiando. Quando ho pubblicato il primo libro, nel 2018, non pensavo alle vendite né alla “categoria”. Poi ho scoperto che i fumetti in Italia vendono più della narrativa, per motivi culturali e generazionali. Non penso affatto che sia un linguaggio minore: penso che alcune persone non siano ancora abituate a leggerlo. Molti lettori mi hanno scritto dicendo: “Il tuo è il primo fumetto della mia vita”. Il mio stile è rapido, diretto, e cerco sempre di semplificare senza banalizzare. Se non capisci una cosa a parole… te la disegno.
Da quale tradizione fumettistica ti senti più influenzata? Europea? Manga giapponesi o altro?
È un mix. Potrei citarti i Mumin di Tove Jansson, Valentina di Crepax, o le autrici manga delle CLAMP, con cui sono cresciuta. E Sailor Moon, ovviamente — imprescindibile per la mia generazione.
Che tipo di pubblico ti legge di più?
Tutti. Sui social vedo un pubblico molto eterogeneo. Ricevo messaggi di adolescenti, adulti, genitori, persone LGBTQIA+, insegnanti. Molti ringraziano perché finalmente leggono una rappresentazione che li riguarda o li aiuta a capire.
Scrivi molto in prima persona. Fino a dove sei disposta a spingerti? Rimane qualcosa fuori?
Se resta fuori qualcosa è solo perché non entra nel libro, non perché voglio censurarlo. Non ho mai escluso cose per vergogna: anzi, ciò che mi mette in difficoltà è spesso quello che devo mettere.
Nasce prima il testo o prima il disegno?
Disegnare è stata la mia prima battaglia, ancora prima del coming out. Credo che tutti possano disegnare: non è talento, è attenzione. Disegnare ti educa a guardare, e guardare ti rende meno giudicante.
Quando incontri il tuo pubblico, ti senti più provocatrice o divulgatrice?
Dipende da come mi sveglio. Ma la mia linea è divulgativa: sento una responsabilità. Non perché voglia fare la morale, ma perché vedo che c’è un vuoto enorme di conoscenza e ascolto.
Come vivi il fatto di essere percepita non solo come artista, ma come simbolo?
Quando questo ruolo peserà troppo, me ne andrò in silenzio. Per ora sto semplicemente cercando un equilibrio: alcune cose voglio che restino solo mie.
Ti sei mai detta vista la situazione forse è meglio che me ne vada dall’Italia?
Sempre. Poi però rimango, perché sono siciliana, testarda, e in fondo ci credo ancora. Se mai me ne andassi, sarebbe forse verso la Spagna, dove stanno facendo politiche molto più avanzate.
Per chiudere: disegnare ti ha guarita almeno in parte?
Mi ha permesso la prima forma di autoanalisi. E finché psicologia e salute mentale resteranno un lusso, scrittura e disegno resteranno strumenti politici. La lotta di classe passa anche dal corpo. E io il mio corpo, finalmente, so raccontarlo.

Josephine Yole Signorelli – Foto Sara Lorusso




